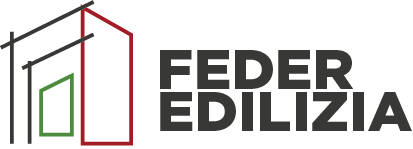Federedilizia: Il Superbonus è stato un’opportunità demonizzata, ma i numeri raccontano un’altra storia
FederEdilizia ritiene necessario commentare il libro: “Superbonus. Come fallisce una nazione” di Luciano Capone e Carlo Stagnaro, Editore Rubettino, giornalisti sedicenti esperti di economia. Questo libro si presenta come un manifesto liquidatorio del Superbonus e si compiace di demonizzare senza appello uno strumento di agevolazione fiscale che comunque ha avuto un impatto economico positivo, fondamentale per l’Italia post-pandemica. Invece di riconoscere il ruolo decisivo del Superbonus nell’innescare una forte ripresa del PIL, il libro si limita a giudizi apocalittici e a semplificazioni grossolane, dipingendo questo strumento come il “più costoso fallimento della storia repubblicana”. Eppure, i numeri veri del PIL e del debito rettificato per gli extra-introiti delle casse dello Stato derivanti, appunto, dal superbonus, raccontano una storia ben diversa: l’Italia ha visto una crescita economica superiore a quella di quasi tutti gli altri Paesi europei, certamente grazie agli incentivi che hanno rianimato l’edilizia e l’intera filiera produttiva. Lo stock di debito dello Stato deve essere necessariamente valutato al netto dei introiti avuti per le sue casse, e non lordo come sbandierato dal libro.
Gli autori, con una vena squisitamente cinica e distruttiva, tendono di fatto a ignorare volutamente il contesto eccezionale in cui il Superbonus è stato implementato: un periodo di crisi sanitaria ed economica senza precedenti, in cui servivano misure straordinarie per rilanciare l’economia tutta. Sarebbe stato invece utile un ragionamento costruttivo ed esperienziale, ovvero ragionare sulla necessità di modulare nel tempo l’aliquota del 110%, adattandola alle mutate e migliorate condizioni economiche. Sarebbe stato doveroso per giornalisti economici di rango, ragionare a tutto tondo sugli effetti diretti ed indiretti del superbonus e non ridursi ad una narrazione demonizzatrice monotematica, utile solo a supportare gli interessi di chi ha effettivamente voluto affossare lo strumento, e il settore, lasciando famiglie e imprese sempre più intrappolate in un ginepraio normativo e finanziario e di contenziosi.
Il libro, insomma, cavalca il solito cliché che accusa il Superbonus di essere un trasferimento “dai poveri ai ricchi” e una zavorra per le finanze pubbliche. Una visione che, più che critica, suona cinica difesa postuma delle scelte politiche di chi ha distrutto questo strumento retroattivamente cambiando le regole, bloccando la cessione dei crediti e lo sconto in fattura con conseguenze devastanti per le imprese, i professionisti e i cittadini che si erano fidati di uno Stato leale. Esperti di economia dovrebbero citare almeno alcuni dati ufficiali (MEF, Istat, AdE, Banca D’Italia, Enea) che documentiamo di seguito. Ad aprile 2024 sono stati generati complessivamente 219 miliardi di crediti fiscali per gli incentivi edili di cui 157 miliardi dal cd “Superbonus“ con compensazione a 4 anni e 62 miliardi per i cd bonus minori (ristrutturazione, ecobonus ordinario, bonus facciate ed altri) con compensazione a 10 anni. Il 45% della spesa è stata immediatamente incassata dallo Stato nell’anno di sostenimento dell’intervento, ovvero un incasso di ben 98,55 miliardi. 15 miliardi sono stati oggetto di sequestro per cui non potranno essere compensati se si accerta che sono vere truffe. Occorre ricordare che era di 33 miliardi la copertura di spesa prevista dal decreto (dl 34/2020) che diede il via al superbonus. Altri 10 miliardi, secondo le stime dell’ufficio studi di FederEdilizia, sono ad oggi i crediti persi dai cittadini, dalle imprese e dai professionisti a partire dal 2023 a causa degli interventi normativi retroattivi che hanno determinato l’impossibilitata della cessione dei crediti. Quindi, occorre detrarre almeno 148 miliardi di ritorni immediati per lo Stato, rispetto una spesa potenziale in crediti fiscali di 219 miliardi spalmata da 4 a 10 anni. Occorre anche contabilizzare gli ulteriori effetti positivi prodotti dagli interventi di efficientamento energetico per minori acquisti di gas e petrolio di almeno 3 miliardi (anno 2022) che si perpetuano per almeno i prossimi 20 anni (3×20=60 miliardi di risparmio utile, qui conteggiati a favore degli autori “esperti di economia” del libro).
Toccherebbe anche quantificare il risparmio in costi salute, calcolo che lasciamo agli autori del libro certamente anche sapienti in materia sanitaria.
Istat, inoltre, ufficializza che gli investimenti nel settore edilizio generano un moltiplicatore di 3.34. Vuol dire che l’impulso di 100 dato dagli incentivi costruiti sul tax credit, viene moltiplicato per almeno tre volte. I punti salienti da considerare:
1. Incremento delle entrate fiscali dirette e indirette
• IVA: Gli interventi edilizi agevolati hanno generato un aumento dei consumi di materiali da costruzione e dei servizi di manodopera, con un conseguente incremento del gettito IVA.
• Tasse su redditi e utili delle imprese: Il boom di attività nel settore edile ha portato a un aumento degli utili dichiarati da aziende e professionisti coinvolti, aumentando l’IRPEF e l’IRES.
2. Crescita dell’occupazione
• La ripresa del settore edilizio ha creato nuovi posti di lavoro, aumentando il gettito contributivo (INPS e INAIL) e IRPEF sui salari.
• L’indotto generato ha favorito anche settori correlati come trasporti, fornitori di materiali edili, e progettisti.
3. Riduzione dell’evasione fiscale nel settore edilizio
• Gli incentivi in edilizia, essendo legati a lavori tracciabili e certificati, ha spinto molte imprese a emergere dal lavoro sommerso per poter partecipare al programma. Questo ha comportato un miglioramento della compliance fiscale.
4. Effetti moltiplicativi sull’economia generale
• Secondo studi (ANCE e Nomisma), ogni euro speso attraverso il Superbonus ha generato un incremento multiplo del PIL, stimolando la crescita economica complessiva e, di riflesso, il gettito fiscale generale.
5. Contrasto al caro energia
• L’efficientamento energetico degli edifici ha contribuito a ridurre i consumi energetici e a mitigare gli effetti economici dell’aumento dei prezzi dell’energia, liberando risorse per i consumi di beni e servizi, con un impatto positivo sul gettito fiscale.
Il libro, infine, non ragiona sull’effetto positivo del piano Biden Inflation Reduction Act – IRA – che ha dimostrato al mondo intero come gli investimenti importanti nella transizione ecologica, composti in massima parte di crediti fiscali, possano effettivamente generare crescita e benefici a lungo termine. Questa omissione appare una censura grave, che conferma il pregiudizio di fondo ostentato dall’opera, ovvero il disprezzo per qualunque misura che implichi una visione proattiva dello Stato per lo sviluppo economico. Un integralismo di sapore post-neo-liberista. Invece di demonizzare e liquidare sarebbe stato più utile e corretto leggere una riflessione complessiva su questa vicenda stimolo su come migliorare e rendere più sostenibili gli strumenti incentivanti dello Stato come il superbonus, imparando anche dagli errori commessi, in un momento cruciale della storia economica del Paese e del mondo.